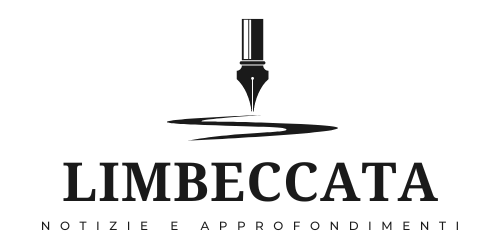Una percezione generale della maggior parte delle persone al giorno d’oggi è che il dolore più grande sia quello di chi è malato o comunque non più autosufficiente; ma c’è un dolore meno visibile, meno discusso, che abita i giorni e le notti di chi si prende cura del proprio assistito: il caregiver, ovvero un familiare, solitamente una figlia o un figlio, che decide di accompagnare una persona cara nel percorso intimo e delicato della fragilità.
In Italia, sono tantissime le persone che si prendono cura ogni giorno di un parente anziano, magari disabile o malato cronico, e la cui vita da un giorno all’altro si è riempita di storie personali, amore, ma anche fatica e rinunce, e, purtroppo, non sempre questa fatica si può raccontare apertamente. A volte, proprio a causa di un forte senso del dovere, si resta in silenzio; altre volte, per senso di colpa, si nega a se stessi anche solo l’idea di chiedere una mano.
Eppure, chiedere aiuto non significa abbandonare chi si ama; non è un segno di debolezza, né una resa, è, semmai, un atto di responsabilità, ed è, per di più, il modo più onesto e umano per preservare sé stessi e continuare a essere presenti. In questo contesto, affidarsi a un servizio di assistenza anziani a Venezia o in qualsiasi altra città, può diventare non solo una scelta utile, ma una forma di rispetto verso sé stessi e verso la persona assistita.
Senso di colpa: quando la cura diventa prigione
Avere i sensi di colpa da caregiver è un malessere complesso, che non nasce da qualcosa di obiettivamente sbagliato, ma piuttosto da un eccesso di amore mal gestito, da aspettative culturali, familiari e personali che si stratificano nel tempo.
Chi si ritrova o sceglie di essere coinvolto nel prendersi cura di un parente anziano spesso finisce con l’imporsi standard altissimi: “Devo fare tutto io”, “Non posso delegare”, “Se chiedo aiuto significa che sto fallendo”, e così, giorno dopo giorno, si costruisce una gabbia invisibile fatta di doveri, rinunciando al riposo, alla socialità, al lavoro, a sé stessi.
Ma è importante sapere che non si può dare tutto senza perdere qualcosa; e quel qualcosa, il più delle volte, è la salute mentale, fisica, emotiva del caregiver stesso. Ansia, insonnia, senso di isolamento, stati depressivi, esaurimento emotivo: sono sintomi comuni, ma spesso ignorati. Sicuramente rendersene conto è il primo passo; ma accettare di aver bisogno di aiuto è la vera svolta. Eppure proprio lì interviene il senso di colpa: “Se chiedo aiuto, sto abbandonando mio padre”, “Se mi prendo un giorno per me, vuol dire che non mi importa abbastanza”.
Ma questo ragionamento, per quanto umano, è profondamente ingiusto. È un circolo vizioso che allontana dalla verità: chiedere supporto è un atto d’amore e di lungimiranza.
Il paradosso dell’altruismo estremo
Spesso, chi fa da caregiver è una persona che nella vita, in un modo o nell’altro, ha sempre saputo prendersi cura degli altri; magari lo ha iniziato a fare con amici, partner o colleghi, ma proprio questa predisposizione, in extremis, può diventare un’arma a doppio taglio.
Basti considerare che, se dare è naturale, ricevere diventa difficilissimo, specialmente quando si è abituati ad essere considerati “quelli forti”, “quelli affidabili”, “quelli che non cadono mai”, e allora, anche solo pensare di dire “non ce la faccio più” diventa inconcepibile: eppure, nessuno può reggere per sempre un peso del genere da solo.
Infatti le energie col tempo si esauriscono, la lucidità vacilla, e si rischia di trasformare l’amore in un automatismo e la presenza in sopravvivenza, e malauguratamente, arrivati quel punto, anche la qualità dell’assistenza ne risente.
Ecco perché è fondamentale rompere il mito del caregiver invincibile: chi chiede aiuto non è meno devoto, ma invece più saggio. La verità è che condividere il proprio carico con gli altri — che sia una figura professionale, un familiare, un amico, o un supporto esterno — permette di essere davvero presenti con qualità, non solo con quantità.
Un gesto di cura verso sé stessi e verso chi si ama
Imparare a chiedere aiuto vuol dire in un certo senso rieducarsi all’ascolto delle proprie emozioni, significa riconoscere i propri limiti non come fragilità, bensì come spazi umani da tutelare.
Esistono diverse forme di supporto emotivo, psicologico, organizzativo pensate proprio per chi si prende cura di altri; pensiamo agli sportelli di ascolto, ai gruppi di sostegno, a percorsi di consulenza familiare, sono tutti strumenti che aiutano il caregiver a ritrovare un equilibrio, a uscire dall’isolamento e infine a ritrovare se stesso.
Per di più sono molte le famiglie che trovano conforto anche nell’affiancare figure professionali per alcune ore alla settimana; non per sostituirsi, ma per affiancarsi, alleggerire e sostanzialmente fare rete: dobbiamo ricordare che non si è meno figli, meno coniugi o meno presenti se si decide di non portare sempre tutto sulle proprie spalle.
Anzi, si diventa più lucidi, più centrati, più capaci di vedere anche ciò che il dolore della fatica spesso nasconde: la bellezza della relazione, la tenerezza di uno sguardo o il valore del tempo passato insieme.
Rompere il silenzio, scegliere la vita
Il senso di colpa è un sentimenti subdolo, che si insinua dove c’è amore e lo trasforma in giudizio, rigidità, sacrificio assoluto, ma un caregiver non deve essere un martire.
Chiedere aiuto non significa arrendersi; significa restare. Significa continuare a esserci, con energia nuova, con lucidità, con presenza autentica. Significa ammettere che non siamo fatti per fare tutto da soli — e che la cura migliore, a volte, comincia proprio da sé stessi. Per questo motivo è importante parlarne, cercare confronto, rompere il silenzio. Perché nel momento in cui il caregiver smette di sentirsi solo, smette anche di sentirsi colpevole, ed è lì che, finalmente, può nascere una nuova forma di cura: più equilibrata, più serena, più umana.